«Questa è la punizione […] Per aver voluto troppo. Per aver pensato di poter essere felici. Felici perché l’avevamo deciso»
Doris Lessing, con Il quinto figlio (1988), mette in scena uno dei più radicali interrogativi sulla famiglia borghese del secondo Novecento, smascherando le fragilità ideologiche di un modello domestico che negli anni ’60 era stato mitizzato come luogo di armonia, stabilità e progresso sociale.
Harriet e David Lovatt incarnano questo ideale: una casa grande, quattro figli, una vita regolata da un ordine quasi rituale. Tuttavia, la nascita di Ben introduce un elemento perturbante (das Unheimliche freudiano) che incrina la narrazione della normalità. Ben non è soltanto “diverso”: è la materializzazione di tutto ciò che la famiglia — e, per estensione, la società — non vuole vedere, non sa nominare e non è capace di includere.
L’opera dialoga con la tradizione del romanzo sociale inglese, ma la oltrepassa, assumendo tratti quasi allegorici. Lessing inserisce la vicenda in una cornice che richiama il dibattito degli anni ’80 sulla genetica, sulla devianza e sulla responsabilità materna, mostrando come la maternità, spesso raccontata in termini idealizzati, sia invece un’esperienza segnata da conflitti interiori, ambivalenza e un senso di colpa sistemico. Harriet diventa così un personaggio emblematico: intrappolata tra l’aspettativa sociale della “buona madre” e la percezione inquietante della radicale alterità del proprio figlio, rappresenta la crisi della soggettività femminile in un contesto ancora dominato da modelli patriarcali.
Se Lessing ha sempre respinto l’etichetta di “autrice femminista”, il romanzo testimonia comunque l’influenza dei movimenti femministi, non tanto per la presenza di rivendicazioni esplicite, quanto per l’analisi delle pressioni che definiscono i ruoli di genere. In Il quinto figlio, la maternità non è un destino biologico ma un costrutto sociale che, quando fallisce, genera isolamento e giudizio. Harriet viene colpevolizzata dalla famiglia e dalla comunità, evidenziando i meccanismi di controllo simbolico esercitati sulle donne: il figlio “non conforme” diventa il pretesto per riaffermare le norme che regolano la maternità.
La dimensione perturbante del romanzo non deriva da elementi fantastici, ma dal loro opposto: dal realismo tagliente con cui Lessing descrive l’impossibilità di comprendere totalmente l’altro, anche quando l’altro è un figlio. In questo senso, Ben è figura liminare: umano e al tempo stesso non assimilabile, richiama le teorie antropologiche sull’“estraneo interno”, colui che abita il margine tra comunità e minaccia. La sua presenza mette in luce la precarietà del legame familiare, smontando l’idea che l’amore materno sia incondizionato o immediato.
Il romanzo oscilla dunque tra la critica sociale e la riflessione psicologica, collocandosi nella scia delle opere che interrogano il mito della domesticità occidentale — da Shirley Jackson a Margaret Atwood — ma con una sobrietà stilistica e una potenza morale che sono esclusivamente di Lessing. La prosa, essenziale e penetrante, evita ogni compiacimento narrativo: il terrore non sta nell’eccezionalità di Ben, ma nel modo in cui la sua presenza fa emergere verità scomode su maternità, famiglia e identità.
In definitiva, Il quinto figlio è un testo che continua a colpire per la sua capacità di mettere a nudo la vulnerabilità umana e la miseria delle aspettative sociali. Lessing costringe il lettore a interrogarsi su ciò che significa amare ciò che non si comprende, crescere ciò che non si controlla e convivere con l’alterità radicale che talvolta irrompe nelle nostre vite. Un romanzo necessario nella sua durezza, essenziale nel suo scardinare certezze, e ancora oggi attualissimo nel porre domande che il discorso pubblico evita: cosa accade quando la famiglia non riesce più a contenere l’angoscia del mondo?
Sofia Sabatino
(bisous)
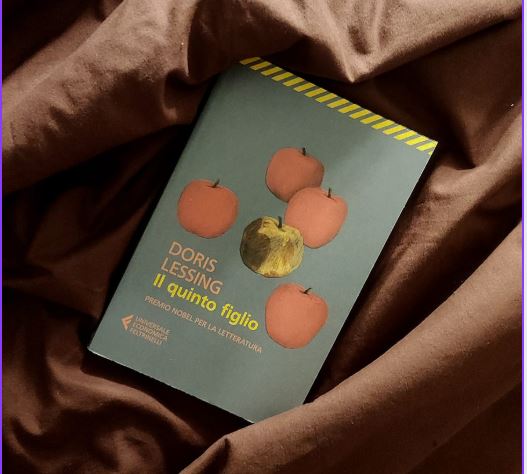
Lascia un commento